
Una chiesa senza preti?
 14 min
14 min
Una chiesa senza preti?
La crisi che la Chiesa attraversa in Occidente, come il recente cammino sinodale ha messo in luce, impone di ripensare l’idea di prete e quella di laico, un cambio di mentalità e di prassi che chiede una ricalibratura dell’azione pastorale e degli organismi di partecipazione per consentire l’esercizio di un’effettiva corresponsabilità. Sarà necessario affrontare questo “cambiamento d’epoca” con coraggio e lucidità, ma anche con la fiducia che nella Chiesa c’è già la risorsa principale: la fede in Cristo Salvatore.
«Quale futuro di una chiesa senza preti? Soglie da varcare» è il titolo di un interessante articolo di don Andrea Toniolo, già preside della Facoltà teologica del Triveneto, pubblicato sul primo numero del 2025 di “Appunti di teologia”, rivista del Centro di studi teologici “Germano Pattaro” di Venezia, proposto di seguito.
oooOOOooo
«Dio voglia che non manchino ai nostri giorni i buoni pastori; Dio non permetta che ne rimaniamo privi» (sant’Agostino, Discorso sui pastori). La preghiera del vescovo di Ippona risulta quanto mai attuale: la preoccupazione diffusa nelle nostre terre riguarda il calo drastico del numero di ministri ordinati, che renderà impossibile garantire il volto di Chiesa finora delineato. La preghiera di sant’Agostino, tuttavia, non è semplicemente per avere pastori ma «buoni» pastori. Non è preoccupato dei numeri ma della qualità. Ad ogni modo, la situazione inaspettata della carenza forte di clero non solo oggi ma anche in futuro preoccupa, con il rischio che diventi ossessione.
Nessuno prevede il futuro e la storia insegna che non sempre le previsioni sociologiche hanno avuto ragione, anche se la demografia non lascia molto scampo. Senza mettere ipoteche sul futuro, specie in ambito vocazionale (ci sono sempre stati momenti di crisi e di ripresa) uno sforzo di immaginazione sulla Chiesa che verrà è necessario. Non possiamo prevedere nei dettagli gli scenari prossimi ma siamo chiamati a preparare la strada perché possa essere tenuta viva la fede e possa esserci ancora l’annuncio del Vangelo.
Almeno tre elementi sono da tenere presenti: il primo riguarda l’idea di Chiesa, il secondo l’idea di prete, il terzo l’idea di laico. La riflessione che segue intreccia questi tre fili.
Partiamo dall’affermazione che la Chiesa cattolica non è pensabile senza ministero ordinato, senza qualcuno che possa presiedere l’Eucaristia e, insieme, una comunità, perché non può esserci una Chiesa senza Eucaristia. Venendo da una pastorale fondata molto sulla quantità delle Messe, questo non significa che basta celebrare la Messa per formare la comunità. La pastorale tradizionale è costruita su questa illusione o pretesa.
L’Eucaristia non è più, specialmente oggi, il punto di partenza ma è il punto di arrivo della fede. Non si comprende l’Eucaristia se non c’è una frequentazione della Bibbia, che prepara la mensa della Parola, e non si comprende l’Eucaristia se non c’è una comunità che cura le relazioni soprattutto con i più fragili, relazioni che preparano la mensa del Corpo del Signore, del pane spezzato, e rendono «vera» l’Eucaristia. Se vale l’affermazione teologica che l’Eucaristia fa la Chiesa perché in essa c’è il DNA del cristianesimo, vale soprattutto nel tempo attuale l’adagio formulato al contrario: la Chiesa fa l’Eucaristia, nel senso che, senza una comunità di relazioni fondate sulla carità, la Messa rimane un rito esteriore, lontano dalla vita.
La cura delle relazioni e l’ascolto della Parola sono il grande e vero offertorio da presentare all’altare, che rendono vissuta la celebrazione Eucaristica, la quale a sua volta diventa nutrimento e forza. Per formare comunità capaci di relazione e di ascolto, ci vuole il contributo di tutti, data la pluralità delle condizioni spirituali; non basta avere preti, ma è necessario valorizzare i carismi di ogni battezzato e individuare ministeri in base ai bisogni pastorali. Questa è la prima conversione a cui le nostre comunità cristiane sono chiamate.
Evidenziato questo, non possiamo dimenticare, però, che nella Chiesa cattolica il ministero ordinato può essere sostituito solo dal ministero ordinato; la struttura sacramentale della fede esige che riceviamo la salvezza mediante dei gesti e persone che rappresentano sacramentalmente l’agire di Cristo (la salvezza non è un nostro merito, ma ci viene donata). Presiedere l’Eucaristia è proprio del presbitero o vescovo, non può essere affidata a un laico o a un diacono. Ma come poter garantire la realtà sacramentale della Chiesa e della fede con pochi preti, sempre più con i capelli grigi e stanchi? Il calo numerico del clero porterà a far scoppiare la figura del prete in pastorale, a renderne impossibile la vita e il ministero.
Per questo va ripensato superando la concentrazione clericale della pastorale ed essenzializzando il ministero dei presbiteri.
La seconda conversione riguarda l’idea e il ruolo del prete. Basta riprendere il dibattito del Vaticano II e la storia postconciliare sul ministero presbiterale per comprendere la fatica di mettere a fuoco la figura del prete pastore, nella Chiesa moderna. Non è un problema teorico ma pratico: riguarda il modo di esercitare il ministero, lo stile di vita, le relazioni con gli altri preti, con i laici, il modo di vivere la propria esperienza spirituale.
E non è questione di qualche aggiustamento della condizione esistenziale o pastorale, ma della rivisitazione di alcuni capisaldi del ministero ordinato, si chiama in causa l’immaginario, la valenza simbolica e sociale costruitasi attorno a tale figura, e, in particolare, la configurazione del “potere” del ministro ordinato.
***
Il ministero specifico dei preti – quello della presidenza – andrebbe pensato e configurato non in forma individuale, ma relazionale, condivisa, «sinodale», e la novità sta nella relazione con gli altri preti e i laici. Il Codice di diritto canonico recepisce un’istanza di condivisione – rispetto al codice del 1917, che non menzionava i laici nella cura animarum del parroco – presentando l’importanza della collaborazione dei laici nella cura pastorale (canone 519). I laici collaborano nella cura della parrocchia: un parroco non governa più da solo; è responsabile dell’intera comunità, ma non da solo.
Da questo punto di vista, sarebbe importante ricuperare la dimensione sinodale e collegiale della presidenza, rispetto a quella individuale. Il Codice prevede la possibilità della guida in solidum con un moderatore di una unità pastorale o più parrocchie (canone 517), ma non mi pare abbia molta fortuna, perché il modo di concepire la guida pastorale è ancora fortemente gerarchico e individuale. La comprensione sinodale della Chiesa, costitutiva, come ha ribadito il magistero di papa Francesco, dovrebbe portare a una revisione giuridica e pratica dell’esercizio dell’autorità del clero.
Nel testo finale del Sinodo sulla sinodalità (ottobre 2024) emerge chiaramente la denuncia del clericalismo, che altro non è che una deformazione del potere del presbitero, una patologia. Antidoto a tale piaga è certamente la prassi della sinodalità, oltre a un lavoro di formazione spirituale, relazionale, psicologica e teologica.
Il potere è necessario per la missione della Chiesa, potere però inteso come capacità di amare, potenza del perdono e del servizio, resistenza al male, come forza della non-violenza, come capacità di tenere viva la speranza, come capacità di edificare una comunità nella fede, come coraggio e autorevolezza della profezia. Seguire Cristo servo e crocifisso non significa scegliere la debolezza, la pusillanimità, l’impotenza, la timidezza.
***
Come si traduce tutto questo nello stile di un presbitero (o meglio più presbiteri) chiamato a presiedere?
La struttura sinodale della Chiesa permette di evitare due estremi: pensare la Chiesa come monarchia/oligarchia (il potere è solo nelle mani di uno o di pochi) oppure la Chiesa come democrazia (per votazione decide la maggioranza). Il potere nella Chiesa è solo quello di Cristo. La Chiesa non è una monarchia o un’oligarchia, perché il potere non è in mano a uno o a pochi, il potere (quello di cui sopra) è sempre di Cristo; il ministero ordinato lo rappresenta sacramentalmente, nella forma che Egli ci ha testimoniato. La Chiesa non è neppure una democrazia perché non è la maggioranza che decide la verità della fede.
Esprimere nel ruolo della presidenza questa comprensione di Chiesa, né monarchica né democratica, ma sinodale («camminare con») non è per nulla automatico; spesso ci si muove tra Scilla e Cariddi, nelle prassi pastorali, tra il rischio della concentrazione di potere e il rischio del semplice coordinamento. Il presidente di un’assemblea eucaristica o di un consiglio pastorale non è il semplice coordinatore dei fedeli o colui che fa il riassunto finale, ma colui che ha la responsabilità (il potere) di promuovere la partecipazione attiva di tutti per il discernimento pastorale. Chiudo con una considerazione su due aspetti importanti da promuovere per pensare una Chiesa con meno clero: la ministerialità laicale e le collaborazioni pastorali.
I ministeri sono come chiamate diverse per l’evangelizzazione, nei tre gradi rinvenibili: quello del cristiano, che partecipa in virtù del battesimo alla missione della Chiesa; quello dei ministeri istituiti e di fatto, che comprende quei servizi nella Chiesa che hanno una certa stabilità e riconoscimento; quello del ministero ordinato, con lo specifico della presidenza: il ministro ordinato presiede l’Eucaristia, in quanto presiede, guida la comunità; presiede alla vita di carità della comunità, facendo convergere i vari carismi presenti, promuovendo la comunione.
***
La valorizzazione dei laici e dei ministeri laicali non dipende solo dalla scarsità del clero (questa è la causa contingente) ma dalla nuova inculturazione del Vangelo che, in un contesto plurale, chiede una pluralità di voci. C’è un grande lavoro di sensibilizzazione da fare con il presbiterio, che spesso fatica a condividere la responsabilità pastorale e dimentica che i battezzati possono fare molto, anche solo in base al Codice: possono amministrare validamente il battesimo, predicare, assicurare la catechesi, presiedere liturgie della parola, i funerali, distribuire la comunione, assistere ai matrimoni, esporre il Santissimo per l’adorazione, visitare i malati, amministrare i beni e molti altri compiti che sono in mano ai presbiteri.
Faccio un piccolo esempio. A molti parroci sono ormai affidate molte parrocchie con migliaia di abitanti. Un prete cui sono affidati 10.000 fedeli ha in media almeno 100 funerali all’anno, vuol dire che quasi un terzo delle sue giornate annuali è dedicato a questo. È un servizio importante e delicato ma non potrà fare molto altro. Non si può pensare – come avviene in alcuni contesti, ad esempio nella diocesi di Bolzano-Bressanone – di formare dei buoni laici per la pastorale dei funerali, liberando in parte il clero per dedicarsi alla formazione dei catechisti e degli educatori dei giovani?
Se, nel contesto italiano, dovessimo sbilanciarci di più nella promozione di figure ministeriali laicali nuove, un incremento rapido di figure stabili ministeriali, a causa della scarsità del clero, comporterebbe alcuni rischi, che non vanno sottaciuti. Innanzitutto, c’è il rischio che per urgenza vengano create figure in una prospettiva puramente funzionalistica, «tecnica», trascurando l’attitudine, la preparazione, la motivazione, la competenza, lo stile.
Un secondo rischio è quello della clericalizzazione dei laici, ossia il pericolo di affidare ai fedeli laici incarichi propri del ministero ordinato (come la guida di una comunità); il ministero ordinato, come si è già detto, può essere supplito solo dal ministero ordinato; e per altro versante c’è il rischio della «laicizzazione della pastorale», ossia il pericolo di relegare il prete solo ad amministratore di sacramenti, ad attività cultuali, mentre ai laici verrebbero affidate tutte le altre attività pastorali (annuncio, catechesi, pastorale giovanile).
Creare, in mancanza di preti, una Chiesa di esperti pastorali non sarebbe certamente la soluzione, anzi potrebbe indebolire l’identità del ministero ordinato, se non ci sono le debite distinzioni, e alimentare ancora uno schema binario dentro la Chiesa: non lo schema clero/laici, ma il binomio «Chiesa di esperti», da una parte, e gente comune, dall’altra. La mentalità della delega è il virus peggiore della ministerialità laicale.
***
Un secondo contesto nuovo che obbliga un ripensamento del ministero ordinato è quello della collaborazione pastorale tra più parrocchie e soggetti. Il nuovo assetto, che si va delineando ormai in tutta Europa, comporta alcuni cambiamenti nel modo di concepire l’esercizio del ministero ordinato e il rapporto preti/laici. La nuova struttura pastorale viene di fatto a cambiare l’identità e il ministero del parroco: responsabile di più comunità, il pastore svolge il ruolo soprattutto di coordinatore di responsabili e di amministratore di sacramenti. La formazione di un prete per più comunità e per la pastorale di cooperazione, e di più preti che collegialmente guidano una unità pastorale, rappresenta il futuro della sua identità e attività.
Per concludere, siamo chiamati non solo a progettare ma anche a cambiare mentalità. La pastorale nel contesto attuale e futuro andrebbe maggiormente pensata nella logica della «prassi rappresentativa», del segno (e meno dei numeri), nella consapevolezza, ancora da acquisire, che la Chiesa non coincide più con la società: «E non dovrebbe essere consolante il solo pensarlo? L’inefficacia che tanti sacerdoti avvertono nella loro fatica di ogni giorno, le tante delusioni, frustrazioni, mancanze di prospettiva che essi provano ora si mostrano sotto una luce diversa. La convinzione di essere chiamati “unicamente” a “rappresentare” le cose che solo Dio produce, a conferire ad esse la dimensione della visibilità e sperimentabilità, non suona forse come messaggio liberante che sgrava nel senso vero del termine il ministero dei suoi pesi, per accollarli allo stesso Signore?» (G. Greshake, Essere preti in questo tempo, Queriniana, 2008).
Fonte:









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Beitragen
Beitragen
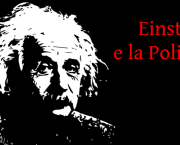



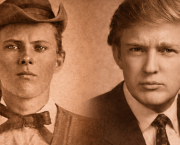



 Du kannst deine Lieblingsautoren unterstützen
Du kannst deine Lieblingsautoren unterstützen





